L'oca nel museo Società

Tutta colpa del nome. Oggi si preferiscono RisiKo e Monopoli, perché il Gioco dell’Oca ha acquisito la valenza offensiva dello starnazzare insieme. Se ne tengono alla larga soprattutto le signore, passate alla Canasta e al Burraco dopo averlo fatto quasi sparire dalle serate di festa casalinghe.
A Napoli è finito nel Museo del Giocattolo dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, una delle più raffinate collezioni di giocattoli antichi presenti sul territorio italiano. E dire che le oche sanno invece organizzarsi in gruppi, sfidare i pericoli e perfino aggredire con astuzia. Anzi, sono così intelligenti che per Konrad Lorenz, padre dell’etologia, chiamare oca una donna valeva un complimento.
Annoverato tra i ‘giuochi da tavola’, quello dell’Oca arrivò nella Benevento pontificia ai primi del Settecento, e le Accademie nostrane ne intuirono presto i significati nascosti. Ma nel sud Italia spagnolo era stato già diffuso dai dignitari della corte di Filippo II re di Spagna, il quale nel 1580 era rimasto affascinato da un tabellone donatogli dal Granduca di Toscana con le caselle a colori disegnate da un ignoto artista del Rinascimento fiorentino.
Nel 1634 il nuovo gioco lo conosceva sicuramente il napoletano Giambattista Basile, autore del famoso Lo cunto de li cunti che al Libro Quinto si apre col racconto intitolato appunto L’oca, protagoniste Lilla e Lalla, due sorelle proprietarie di un’oca che anziché uova produceva monete d’oro, creando infiniti problemi. “Impedimento però è spesso giovamento” conclude l’autore, alludendo ai rischi da superare casella dopo casella fino all’eventuale premio finale.
Qualcuno oggi pensa che l’avventuroso itinerario di 63 caselle - poi diventate 90 - derivi da arcaiche rappresentazioni simboliche delle difficoltà della vita, per esempio dai labirinti di Cnosso a Creta, di Meride in Egitto e, in Toscana, dal labirinto del re etrusco Porsenna che in forme misteriose invade il sottosuolo della piazza del duomo a Chiusi presso Siena.
Quelle complicate strutture architettoniche non servivano certo per giocare alla “paparella con i dadi”, come si diceva una volta a Benevento, né per Giochi dell’Oca vivente come oggi da qualche parte si usa, ma per esigenze pratiche e forse anche per indurre, in chi vi penetrava, sensazioni di perdita e far riflettere sul coraggio necessario ad affrontare scelte e fatalità ineludibili.
Per questo, il Gioco dell’Oca non va visto soltanto come uno svago tradizionale in attesa della mezzanotte, dove se finisci sulla casella del Ponte puoi raddoppiare i passi, se arrivi in quella della Locanda devi restarci fermo per tre turni mentre gli altri ti sopravanzano, e se cadi nel Pozzo puoi solo sperare che un altro giocatore venga a rimpiazzarti.
Quel gioco sa immergerti come pochi altri in un intrigo d’emozioni analogo al viaggio umano attraverso il tempo, fatto di passi avanti e ritorni scoraggianti, di perdite improvvise e premi inaspettati, secondo il responso dei dadi lanciati dalla mano che trema.
ELIO GALASSO
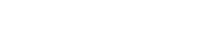
 21/12/2016
21/12/2016














